Fabbriche e fabbricanti di ceramica a Monte Milone.
Le vicende, i personaggi, la cronologia e
l’ubicazione delle fabbriche.
I
testi che seguono, pubblicati qui per la prima volta, costituiscono un
approfondimento della parte generale, contenuta nei precedenti capitoli,
relativo ad un arco temporale compreso tra la metà del XVIII sec. e gli inizi
del XX, dove ho cercato di esaminare, per ogni singola fabbrica, alcuni aspetti
legati alle vicende dei ceramisti che le fondarono o ne furono i direttori e,
soprattutto, di fornire un quadro cronologico con la successione degli stessi. Una
sintesi può essere facilmente consultata nella tabella con il titolo
“Cronologia delle fabbriche”. L’ultimo aspetto preso in considerazione è
l’ubicazione di queste ultime nel contesto urbano, laddove è possibile
indicare, nella maggior parte dei casi, l’esatta collocazione[1].
Ho individuato, con alcune brevi note previe, tutti questi immobili su una
mappa catastale antica riprodotta alla fine del testo[2].
Marco
Caprari
Da un altro atto notarile del 28
novembre 1772 apprendiamo tuttavia che Marco, a' fine di assimersi da debiti da se contratti, per li quali è stato
anche ristretto in queste Carceri Pretorali vende a suo padre Nicola una casa,
che esso Marco comprò da Anton Niccola Andreani al presente ridotta ad uso di
Vasaria posta dentro questa Terra in Contrada di S. Bartolomeo... [6]
Accordarei a Marco Caprari Vasajo di poter porre il macinetto nel nostro Vallato colle condizioni, ed obblighi espressi nella Supplica ridondando ciò in vantaggio della nostra popolazione.
Accordarei
a Marco Caprari l'apposizione dell'altro Macinetto a condizione di dover dare a
capo a tre anni la credenza, conforme ha dato l'altro Vasaro Ferrini con ponere
il detto Macinetto in distanza, che non debba pregiudicare ai Macinetti
precedentemente accordati al Ferrini, e che intanto paghi la Regalia in cera di
altre due libbre, e si ponghi in una distanza che non pregiudichi ai terreni
della Comunità.[9]
La sua attività di vasaio presso la
fabbrica della Collegiata durò fino al 1789, anno in cui gli Assortati decisero
di affidare la vaseria a Luigi Venanzoli. Quest'ultimo avrebbe garantito una
produzione migliore e sicuramente in grado di competere con quella del
Verdinelli dato che aveva lavorato per diversi anni sotto la sua direzione. Il
Caprari dovette allora cercare un altro immobile nel quale aprire una nuova
fabbrica che è possibile identificare con quello di via del Borgo, passato
successivamente al Rosati. Dai carteggi relativi alla disputa per i macinetti
nel vallato del fiume Potenza apprendiamo, infatti, che i diritti di prendere
acqua dal mulino, acquisiti da Marco Caprari, passarono a felice Rosati. Pur
non avendo una conferma definitiva possiamo affermare, per quanto attiene ai
carteggi sul molino del Potenza, che questi appartengono all'epoca in cui il
Rosati era vivente ed operante e ciò fa ritenere la fonte abbastanza
attendibile.
Non sappiamo con certezza fino a
quando il Caprari esercitò la professione di fabbricante di maioliche ma
sicuramente, nei primi anni dell'800, abbandonò l'attività per abbracciarne
un'altra, come risulta da una lista di spese del Convento di S. Francesco di M.
Milone risalente al 1808, dove leggiamo che erano dovuti 88 baiocchi a Marco
Caprari fornaio per la cocitura del pane[12].
Morì a Monte Milone il 4 marzo 1821[13].
Fabbrica
di via Santa Maria.
Pacifico Sileoni aveva appreso
l'arte del vasaio presso la fabbrica dei fratelli Ranieri mentre Beniamino
Rosati in quella dello zio, Felice Rosati, come risulta dall'elenco degli
operai delle fabbriche del 1830. La loro attività dovette tuttavia cessare
momentaneamente prima del 1857, poiché il loro nome non risulta tra quello dei
fabbricanti di maioliche nel ruolo dei contribuenti per la tassa di esercizio
delle arti e del commercio dello stesso anno[18].
Inesistenti le notizie relativamente
agli anni fino al 1861 quando, dalla Statistica Minerale apprendiamo che la
"quinta fabbrica", situata all'interno del paese e con fornace a
funzionamento permanente, era passata sotto la direzione di Serafino Nardi e
Niccola Rossetti[19].
Di quest'ultimo sappiamo soltanto che aveva lavorato sin da giovane presso la
fabbrica di Serafino Verdinelli.
Il proprietario dell'immobile era,
ricordiamolo, ancora Pacifico Sileoni che seguitava a praticare nel 1863
l'attività di fabbricante di maiolica. Non è facile districarsi in questo
groviglio di nomi e di date ma un certo chiarimento ci viene fornito da un
documento di quattro anni successivo, l'elenco delle fabbriche nel 1865[20],
dove risultano essere direttori della vaseria Serafino Nardi e Compagni. Fra i
soci del Nardi doveva essere, dunque, anche il Sileoni e probabilmente i
maiolicai sopra citati e, forse, altri vasai di cui non conosciamo il nome. Sta
di fatto che alle tormentate vicende della fabbrica nei primi anni della sua
esistenza fece seguito un periodo abbastanza stabile dopo che il Nardi ne
assunse la direzione.
Negli anni seguenti dovettero
entrare a far parte della vaseria i nipoti di Serafino: questi seguitarono
l'attività insieme allo zio tanto che uno di loro, Luigi, il 25 aprile 1871
acquistò la fabbrica da Pacifico Sileoni e dalle sorelle comproprietarie[21].
Nel 1872 avvenne la divisione del
patrimonio della famiglia Nardi. Dal relativo atto notarile[22]
veniamo a conoscenza che Giuseppe ricevette dai fratelli Luigi, Benedetto e
Marino la quota a lui spettante su parte dei beni comuni: quanto del negozio tuttora esistente ed utile della Fabbrica di Majoliche,
e ne fece in favore dei fratelli cedenti ogni opportuna e finale quietanza
... Ciò dimostra che Luigi, pur figurando come unico acquirente nell'atto di
acquisto della fabbrica, era comproprietario della stessa insieme ai fratelli[23].
L'attività di questi ultimi nella fabbrica dovette tuttavia essere di secondo
piano rispetto al ruolo svolto da Luigi che ne era direttore e figurava sempre
come proprietario negli atti ufficiali. Inoltre i pochi pezzi firmati a nostra
conoscenza riportano sempre le sue iniziali. Anche nella "Statistica degli
Operai" del 1878[24]
Luigi figura come proprietario dell'opificio in cui, stando alle notizie
riportate sulla scheda, lavoravano 18 persone dai 10 ai 60 anni in orari
variabili dalle 8 alle 14 ore giornaliere. Sempre dallo stesso documento
apprendiamo che la fabbrica era situata all'interno del paese con sei locali posti in favorevole posizione e
in condizioni igieniche definite buone.
La breve vita di questa vaseria si
concluse verso la metà degli anni '80. Quando venne venduta, nel 1886, non
aveva più la stessa destinazione d'uso e viene definita nel rogito notarile
semplicemente come casa[25]. È
in questo periodo che l'attività di Luigi Nardi si trasferì nella fabbrica di
via del Borgo lasciata libera dai fratelli Rosati che avevano oramai cessato la
loro attività.
Fabbrica di via del Borgo.
Se si eccettua la breve parentesi
dell'utilizzo, in affitto, dell'immobile presso la Porta del Colle, l'attività
della fabbrica Rosati resta documentata sin dal 1806, dalla statistica delle
fabbriche del 1808, dove risulta che venivano impiegati tre lavoranti, compreso
il proprietario e due operai. Stando a quanto asserisce il Corona[27]
Felice Rosati[28]
apprese l'arte del vasaio presso la fabbrica di Francesco Verdinelli: la
notizia è confermata dallo scritto dell'Assortati sulle botteghe agli inizi del XIX secolo.
Come le altre fabbriche coeve in
territorio di M. Milone, ad eccezione di quella degli eredi Verdinelli Ferrini,
anche questa ebbe nel primo quarantennio del secolo un periodo di eccezionale
floridezza economica. Lo testimoniano alcuni atti notarili dell'epoca dai quali
risulta l'acquisto di alcuni immobili e il pagamento di molti dei debiti
contratti per l'avviamento della fabbrica che subì, inoltre, due ampliamenti
nell'arco di un biennio. Il primo, nel giugno 1824, con l'acquisto di un orto[29]
l'altro, nel settembre 1825[30], con
l'acquisto di una casa, confinanti entrambi con la vaseria. Oltre a ciò va
fatto notare come dalle iniziali cinque persone occupate si passò ai 26 uomini
impiegati, tra lavoranti e garzoni, intorno al 1830[31].
Felice Rosati lasciò tutti i suoi
beni immobili[32]
ai tre figli maschi Gaetano, Generoso e Giuseppe con la raccomandazione,
contenuta nel primo testamento, che debbano
essere Attenti, e vigilanti all'andamento della Fabbrica di Majoliche.
Oltre agli immobili però, i tre fratelli ereditarono anche parecchi debiti
contratti dal loro genitore per far fronte agli ultimi pagamenti per 400 scudi
al Reale Collegio di S. Clemente di Spagna in Bologna, in saldo del prezzo di
un fondo rustico acquistato nel 1827, e per la ristrutturazione dell'immobile
dove aveva sede la fabbrica di maioliche, per un importo di 300 scudi, avendo
creato un censo in favore della Collegiata di S. Biagio di M. Milone
nell'aprile del 1833[33].
Come si può leggere da un Decreto del Governatore di Treia del 1845, la
situazione economica degli eredi Rosati dopo la morte del padre era non certo
delle migliori:
Nello stesso anno i fratelli Rosati
vendettero la vaseria ai due cognati Pasquale Nardi e Mariano Luchetti [40] per
restituire le doti alle sorelle e per le quali, precedentemente, era stata
posta un'ipoteca sullo stesso immobile. Ciò nonostante i Rosati seguitarono la
loro attività di maiolicai, sia pur in modo discontinuo, come dimostrano altri
documenti degli anni successivi. Innanzitutto la statistica del 1861[41]
nella quale riappare il nome di Generoso Rosati come esercente di una fabbrica di stoviglie che, a differenza delle
altre a carattere permanente, aveva
la fornace a carattere temporario
ovvero funzionante saltuariamente. Si hanno poi ulteriori notizie della
fabbrica nei documenti relativi al Concorso a Premi del 1879, organizzato dalla
Camera di Commercio ed Arti di Macerata[42], al
quale Generoso Rosati partecipò, esponendo stoviglie
diverse in majolica e ottenendo la medaglia di bronzo nella classe terza,
quella dei prodotti in ceramica. Fra gli stessi documenti si conserva anche una
lista degli oggetti esposti con i relativi prezzi di vendita, scritta di
proprio pugno dal Rosati, che ci fornisce un interessante quadro della
produzione di oggetti di uso comune della sua fabbrica:
Pollenza 16/8/79.
Robba per l'esposizione di Macerata.
Piatti
bianchi alla
dozzena £ 1,50
Piatti
colorati idem £
1,40
Mezzi
reali bianchi idem £
3,00
Reali
Colorati idem £
6,00
Servizi
da Camera Liscio £
1,75 l'uno
Servizio
scannellato £
2,00 idem
Terine
da 6 persone bianche £
1,00 idem
Terine
da 4 persone idem £
0,80 idem
Barattoli
per tabaco
opure
altri capi di robba £
1,00 idem
Cuccoma
per latte £
0,35 idem
Pezzi
piccoli per uso d'ospedale £
0,15 idem
Bucalette £
0,25 idem
Catino
da comodo £
0,70 idem
Orinale
da comodo £
0,80 idem
Orinale
doppio £
0,80 idem
Catino
per uso da far-
macista
da due litri £
0,60 idem
Vasetti
da chiesa per uso di compagnia £
0,60 idem
Vasi
da fiori al paglio £
0,80 idem
Rosati
Generoso
Quasi tutti i termini utilizzati
nell'elenco sono facilmente comprensibili eccetto alcuni arcaismi o parole in
gergo quali reale, che lo scrivente
usa con il senso di piatto grande, terina,
ovvero zuppiera e cuccoma,
caffettiera.
L'attività dei Rosati come maiolicai
continuò fino agli anni intorno al 1880. L'ultimo documento in cui Generoso
viene definito fabbricatore di maioliche
è un atto notarile del 16 novembre 1880[43]
mentre Gaetano, stando ancora ad un atto notarile del 1884, esercitava la
stessa professione a quella data[44].
Dobbiamo comunque ricordare che nel
1872 l'immobile in cui aveva sede la fabbrica di via del Borgo era passato
sotto l'intera proprietà di Pasquale Nardi. che, come l'ex comproprietario
Mariano Luchetti, non era un fabbricante di maiolica[45]. I
Rosati tennero quindi la fabbrica in affitto fino al termine della loro
attività quando, dopo il 1880, subentrò Luigi Nardi, cugino di Pasquale, come
direttore. Non conosciamo la data precisa del passaggio dai Rosati al Nardi, ma
questa avvenne prima del 1886, anno in cui Luigi vendette l'immobile di via S.
Maria[46].
Quest'ultimo, morendo nel 1888 e non avendo eredi diretti, lasciò i suoi beni
ai nipoti[47],
fra cui Alessandro, che gli successe come direttore della vaseria. Nel 1892
venne rinnovato il contratto di affitto per ulteriori sette anni e per una
somma di 1200 lire per tutto il settennio[48], con
la possibilità di prorogarlo di anno in anno una volta scaduto il termine.
L'opificio ebbe un destino simile a
quello di quasi tutti gli altri nel paese, chiudendo definitivamente agli inizi
del nostro secolo, come risulta da una lettera[49] del
Sindaco del Comune di Pollenza, al Presidente della Camera di Commercio di
Macerata del 1908, inviata in occasione della Statistica delle fabbriche di
terraglie, maioliche e porcellane di quell'anno:
Mentre assicuro la S. V. Ill.ma di aver provveduto al
recapito della circolare trasmessami col foglio a margine, alla Ditta
Venanzoli, le restituisco quella della Ditta Nardi Alessandro che da qualche
anno ha chiuso l'esercizio".
Fabbrica
presso la Porta del Colle. Le vicende dalla metà dell’800.
Sappiamo
già che Serafino Verdinelli e sua moglie Aloisia Fedeli decisero di vendere la
fabbrica presso la Porta del Colle, nel 1853, al possidente montemilonese
Vincenzo Moroni. L'atto di compravendita[50]
riporta un particolare interessante, che vale la pena di citare, e cioè che dell'immobile viene più volte
definito casamento ad uso di fabbriche di
majoliche, tanto da far pensare che il Verdinelli, nell'ultimo perido della
sua attività condivise l'edificio con un altro fabbricante. La perizia di
stima, allegata all'atto notarile, parla tuttavia di fabbricato ad uso di fabbrica di majolica. Questo documento
fornisce un'interessante descrizione relativa alla sua conformazione interna ed
alla sua ubicazione in ambito urbano:
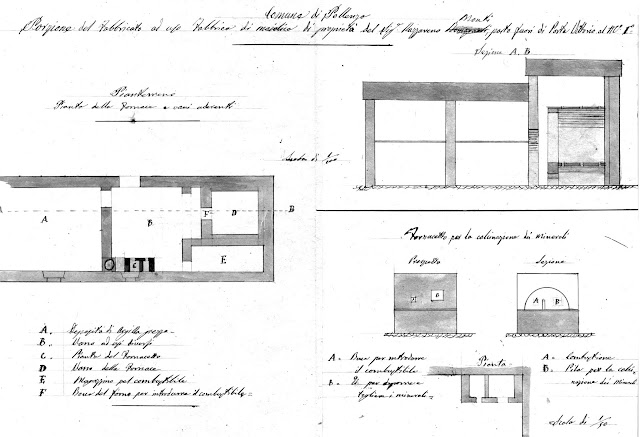 |
| Figura 1. Rilievo delle fornaci della fabbrica della Porta del Colle, disegnato nel 1889 dal perito Egidio Nardi. |
Il maiolicaio che divise la fabbrica
col Verdinelli, qualora fosse vera questa circostanza, altri non poté essere
che Niccola Benedetti. Fu questi infatti, come attestano alcune statistiche
dell'epoca, il successore di Serafino: ma la sua attività come direttore di
vaseria non iniziò in quella della Porta del Colle. Il Ruolo dei Contribuenti
del 1850 infatti, primo documento in cui viene nominato fra i maiolicai
montemilonesi, ci informa che esercitava in uno stabile nell'interno del Comune, che possiamo individuare quasi con
certezza come quello di via del Borgo, momentaneamente lasciato libero dai
fratelli Rosati. Dallo stesso Ruolo sappiamo inoltre che il Benedetti, come
tutti gli altri, fabbricava mezza maiolica, aveva tre dipendenti e un capitale
di 100 scudi. Il fatto che non sia presente nell'Elenco a Stampa dei Commercianti
della Provincia del 1849 ci porta con sicurezza a datare l'inizio della sua
attività nel 1850.
Qualche anno dopo, nel 1856, in
quello che potremmo definire il periodo forse peggiore, a livello economico,
per le fabbriche montemilonesi, non riuscirà per i pochi guadagni realizzati a
pagare la Tassa per l'Esercizio delle Arti e del Commercio: due anni dopo
otterrà la grazia, da parte del Delegato Apostolico di Macerata, vedendosi
condonata, come era successo per altri maiolicai, la metà dell'importo da
pagare.
Superato questo periodo di crisi
restò attivo ancora per diversi anni, sicuramente fino al 1865, come documenta
l'elenco dei fabbricanti di maiolica di Pollenza che avrebbero dovuto
partecipare all'Esposizione Provinciale di Macerata in quell'anno.
Il suo successore presso la vaseria
della Porta del Colle fu Antonio Farroni. L'unica notizia che possediamo sulla
sua attività di maiolicaio ce la fornisce la Statistica del 1878[51],
dalla quale risultano impiegati nel suo opificio 14 operai, dai 10 ai 60 anni,
in 5 locali posti in favorevoli
condizioni igieniche.
Nel dicembre del 1887 cedette la
fabbrica al genero, Nazzareno Monti, ed alla figlia Adelaide per 1750 lire.
Dall'atto di compravendita apprendiamo che furono
i signori acquirenti immessi al possesso fin dal 1° Gennajo 1887 ... avendo il
Sig. Farroni cessato dall'esercizio di detta Fabbrica, che è passata ai
cessionari coniugi, fin dalla detta epoca ...[52].
Soltanto un anno dopo il Monti
partecipò alla Mostra Provinciale Operaia di Camerino, in qualità di fabricatore di maioliche, ottenendo la menzione
onorevole nella Classe VIII, Sez. I, comprendente Prodotti per famiglia, Utensili di metallo e terracotta[53].
Nazzareno era nato a Monte Milone
nel 1853 da Niccola[54], con
molta probabilità lo stesso che insieme a Sante Monti si era trasferito a
Fabriano, dopo il 1860, per andare a lavorare nella fabbrica Miliani. Anche lo
stesso Nazzareno alcuni anni dopo, nel 1881, si era trasferito a Fabriano dove
poté completare la sua formazione come vasaio[55]. Pertanto
appare lecito affermare che, una volta tornato al paese di origine per rilevare
la fabbrica del suocero, portò con se parte delle esperienze maturate a
Fabriano così come il suo genitore fece qualche anno prima quando, partendo da
Pollenza, portò con se molto del repertorio allora in uso nelle fabbriche del
paese. Ciò spiegherebbe, ad esempio, la produzione pollentina di terraglia ad
uso inglese molto simile, come noto, a quella che si cominciò a produrre nella
città di Fabriano intorno alla metà del XIX secolo.
Molti degli oggetti realizzati nella
fabbrica Monti sono contrassegnati dai marchi "N. Monti-Pollenza" o
"La Croix-Pollenza".
Dobbiamo infine ricordare che la
vaseria Monti rimase attiva fino al 1920 circa e che, negli ultimi anni, si
avvalse della collaborazione del pittore Giuseppe Fammilume[56].
Fabbrica
presso la Collegiata.
Altre preziose notizie sulla
famiglia Venanzoli, sulle loro origini e sul negozio di vasaria, ci vengono fornite dal manoscritto di Domenico
Assortati[58]:
Il detto
Luigi adunque era bravo lavorante ... Finché visse il detto Ferrini, fù nella
sua Bottega, dopo continuò con i due suoi figli nella medesima professione
sotto Francesco Verdinelli lasciato Erede dal detto Ferrini: disturbatosi
credette iniziare[?]
una nuova bottega, non ostante che il detto Verdinelli avesse ottenuto dal
Pontefice Pio VI una privativa di Vasi a guisa di Majolica per anni 10, se non
erro. Aperto detto negozio, e venutogli a seconda de suoi desideri, sminuiva il
denaro al Verdinelli, quale coll'arco teso gli procurava prendere il detto
Venanzoli in fallo, come gli riuscì, e frà le altre volte, una fù nella Fiera
dopo le Pentecoste in Treja, che molto lo disestò. Morto il Verdinelli,
terminata la detta privativa si dette tutto l'impegno per accrescere il
negozio, ed assistito dai suoi Figli, ha potuto in poco tempo eguagliare il
negozio Ferrini. Intanto comprò una Casa, ..., ed è quella dove abitano
presentemente poi l'altra alla medesima contigua ... e finalmente morto il Sig.
Giuseppe Catoni marito di Settimia mia Sorella senza successione, la medesima
avendo avuto da Noi per porzione di dote la Casa ...; la detta Sorella ricevuta
detta casa per conto di sua dote dall'Erede proprietario Sig. Francesco
Marchetti la medesima la di poi venduta al Venanzoli per il prezzo di scudi 1100
... alla moneta che valeva in quell'epoca. La detta Casa è quella dove oggi i
Fratelli Venanzoli tengono il negozio di Vasaria, nella quale antecedentemente
al matrimonio di essa Sorella vi era il negozio Ferrini Verdinelli situata nel
quartiere S. Maria da tré lati le strade, e dall'altro le mura castellane. I
Figli pertanto avuti detto Luigi da Francesca sono, Giuseppe ... Lorenzo che è
attuale capo di Bottega assistente alla medesima è bravo lavorante, avendo molto
contribuito nel principio del negozio a suo Padre, ed è nubile. Antonio, ma di
poca abilità in detta professione, è solamente buono nelli lavori di stampa,
conforme a suo Fratello Giuseppe ...
Antonio Venanzoli morì nel 1838
lasciando in eredità[61] la
sua parte della vaseria ai sette figli maschi Venanzo, Giacomo, Ignazio,
Alessandro Pio, Celestino e Niccola. Lorenzo morì il 25 febbraio dell'anno
successivo e, non avendo eredi diretti, lasciò i suoi beni agli stessi nipoti[62].
La fabbrica continuò la propria
attività sotto la direzione di Ignazio: è questo il nome che maggiormente
figura nei documenti ufficiali dell'epoca, statistiche o ruoli dei
contribuenti. Così nell'Elenco a stampa dei Commercianti della Provincia del
1849[63] e
nei Ruoli del 1850[64] e
1858[65].
Dalla Statistica degli Operai del 1878[66]
apprendiamo che la fabbrica di maioliche di Ignazio Venanzoli occupava 15
operai maschi dai 12 ai 60 anni in 5 locali dislocati in posizione favorevole.
Null'altro conosciamo della figura
di Ignazio a parte il fatto che, nel 1867, fu tra i fondatori della
"Società operaia di Mutuo Soccorso" di Pollenza e che ne resse,
provvisoriamente, la presidenza.
Morì il 3 marzo 1879, all'età di 67
anni, e gli successe nella direzione della vaseria il figlio Giovanni.
Giovanni Venanzoli (M. Milone
22.08.1846 - 21.09.1900) è certamente il più importante fra i maiolicai che
operarono a Pollenza nella seconda metà del XIX secolo, colui che più degli
altri fabbricanti ottenne meriti e riconoscimenti anche in ambito nazionale,
nonostante l'epoca in cui visse ed operò non riconobbe, forse, tutto il suo
valore.
Il suo esordio avvenne nel 1879 con
il concorso a premi, organizzato dalla Camera di Commercio di Macerata, dove
espose Stoviglie di majolica e oggetti di
terracotta il cui elenco venne stilato sulla carta intestata della ditta
"Giovanni Venanzoli fabbricatore di maioliche Pollenza"[67]:
Li 29 Agosto 1879.
Elenco degli articoli di maiolica che si consegnano nella
Camera di Commercio per l'Esposizione provinciale di Macerata, e prezzi
rispettivi
|
N° |
6 |
Piatti grandi filettati celeste bianchi |
Dozzena |
£ 1 |
70 |
|
² |
6 |
id
mezzani id |
" |
" 1 |
40 |
|
² |
4 |
id id filettati orange |
" |
" 1 |
60 |
|
² |
2 |
id id bianchi |
" |
" 1 |
40 |
|
² |
2 |
id ordinari
filettati orange |
" |
" 1 |
30 |
|
² |
2 |
id id colorati bleu |
" |
" 1 |
50 |
|
² |
12 |
id id
diversi |
" |
" 1 |
15 |
|
² |
3 |
id mezzoreali figurati |
Ciascuno |
" 1 |
45 |
|
² |
1 |
Insalatiera reale figurata |
" |
" = |
70 |
|
² |
1 |
id id bianca |
" |
" = |
50 |
|
² |
1 |
id mezzana id |
" |
" = |
40 |
|
² |
1 |
id cupa grande colorata |
" |
" = |
50 |
|
² |
1 |
id id id bianca |
" |
" = |
40 |
|
² |
1 |
id id mezzana
colorata |
" |
" = |
30 |
|
² |
1 |
id id id bianca |
" |
" = |
25 |
|
² |
2 |
id piccole colorate |
" |
" = |
14 |
|
² |
2 |
Fruttiere 1a bianca 1a colorata |
" |
" 4 |
= |
|
² |
1 |
Servizio da Camera a fascione orange |
" |
" 2 |
50 |
|
² |
1 |
id id bleu |
" |
" 2 |
25 |
|
² |
1 |
id bianco
ordinario |
" |
" 1 |
90 |
|
² |
3 |
Brocco - Catino - Orinale bianco |
Tutto |
" 1 |
70 |
|
² |
1 |
Bidè vernice ordinaria |
Ciascuno |
" 2 |
30 |
|
² |
1 |
Vaso grande |
Paio |
" 12 |
|
|
² |
2 |
id piccoli |
" |
" 4 |
50 |
|
² |
1 |
Lampada da giardino a Bronzo |
Ciascuna |
" 4 |
|
|
² |
1 |
id id rossa |
" |
" 4 |
|
|
² |
1 |
id id grezza |
" |
" 1 |
|
|
² |
1 |
Portaritratto dorato |
" |
" 1 |
40 |
|
² |
|
id a bronzo |
" |
" = |
70 |
|
² |
|
id rosso |
" |
" = |
70 |
|
² |
|
id grezzo |
" |
" = |
40 |
Macerata 29 Agosto 1879
Giovanni Venanzoli espositore
Tra gli oggetti dell'elenco
riconosciamo con sicurezza alcuni pezzi molto comuni appartenenti al repertorio
della fabbrica Venanzoli o degli altri opifici pollentini della generazione
precedente a quella di Giovanni che, essendo agli esordi, dovette presentarsi
al concorso con un serie di oggetti, dalle forme oramai collaudate, ma prive
ancora della sua impronta personale. Fra questi oggetti appaiono sicuramente i
servizi da camera, vaso, brocca e catino, che sono stati descritti nel capitolo
sulla seconda metà dell’800. A questo periodo appartengono anche i pezzi
riportanti il marchio impresso in pasta, "GIOIA", l'acrostico nel
quale Giovanni volle accostare l'iniziale del suo nome a quelle del padre
Ignazio e del nonno Antonio.
Dall'elenco dei premiati apprendiamo
che la ditta Giovanni Venanzoli risultò prima nella Sezione III, Ceramica,
ottenendo la medaglia d'argento e un premio di £ 20.
Soltanto due anni dopo, nel 1881, il
Venanzoli partecipò all'Esposizione Italiana di Milano ottenendo la menzione
onorevole nella Sezione XII, quella della ceramica e vetraria.
Nel 1884 prese parte alla Mostra
Nazionale di Torino ottenendo analogo riconoscimento. Sulla scheda per la
domanda di ammissione, presentata alla Giunta Distrettuale di Macerata,
possiamo leggere una breve descrizione degli oggetti da esporre, costituiti da
alcuni articoli di maiolica pitturati uso
antico ... e sospensioni per fiori in maiolica[68].
A quest'ultima esperienza fece
seguito un breve e infruttuoso rapporto d'affari con un commerciante torinese,
tale Emilio Paradisi, incaricato di vendere i pezzi spediti per l'esposizione.
Come si può leggere da un carteggio dell'epoca[69], il
Venanzoli non solo non riebbe indietro i pezzi inviati per la mostra e
tantomeno il ricavato dalle vendite ma, avendo spedito un ulteriore carico di
ceramiche nel dicembre 1884, ancora nel giugno 1888, non avendo avuto riscontri
sul materiale inviato, dovette rivolgersi al presidente della Camera di
Commercio di Macerata che, in una lettera al Paradisi, così scriveva:
Stando alle notizie forniteci dal
vasaio Nazzareno Benedetti, Giovanni Venanzoli si avvalse della collaborazione
del pittore Guido Bianchedi. Non conosciamo i limiti temporali della sua
attività nella bottega dei Venanzoli ma, con molta probabilità, vi entrò a far
parte dopo che suo padre Niccola cedette la fabbrica di maioliche ad Antonio
Bellini. Difficile pure, allo stato attuale, isolare lo stile delle sue
decorazioni fra quelle che riportano i pezzi realizzati da Giovanni Venanzoli.
Della sua opera ci resta tuttavia un disegno della fabbrica (figura 2),
raffigurante il suo interno, che, anche in base ad una dichiarazione resa da
Ignazio Venanzoli[70],
risulta essere molto fedele a quella che doveva essere la reale situazione del
laboratorio al momento. Anche nell'immagine sacra sulla parete di fondo, sopra
la scritta "W S. ATONIO AVVOCATO DI POLLENZA", è possibile
riconoscere una stampa del Santo con veduta di Monte Milone sullo sfondo, della
quale esistono ancora alcuni esemplari nel paese, particolare questo che sembra
fugare ogni dubbio sul valore documentario del disegno stesso. Importanti, ai
fini del presente studio, sono gli oggetti raffigurati sulle scaffalature
laterali, tutti di uso comune, sui quali ci soffermeremo. La scena sembra
infatti contenere una selezione della produzione minore della fabbrica e tutti
i pezzi in essa rappresentati sono diversi a seconda degli scaffali dove
possiamo notare 6 tipi diversi di brocche, 3 diverse ciotole, 5 tipologie di
boccali, 3 di vasi, 4 di piatti, 3 di bottiglie, un albarello in fase di
lavorazione e 2 contenitori da cucina di cui uno per il caffè.
 |
| Figura 2. Guido Bianchedi, disegno raffigurante l’interno della Fabbrica Venanzoli alla fine dell’XIX sec. Pollenza, Museo Comunale. |
Dopo la morte di Giovanni, avvenuta
nel 1900, la fabbrica continuò la propria attività sotto la denominazione
"Ditta Giovanni Venanzoli - Pollenza": i pezzi realizzati in
quest'ultimo periodo sono riconoscibili per il marchio impresso in pasta,
riportante la stessa dicitura.
Nel 1905 ebbe luogo la prima
Esposizione Regionale Marchigiana, che si tenne a Macerata nei mesi di agosto e
settembre, dove la Ditta partecipò nel gruppo 7°, Classe 31, maioliche e
porcellane, ottenendo la medaglia d'oro.
Alla stessa manifestazione l'erede
di Giovanni, Ignazio, espose nella sezione Arte Antica cinquanta pezzi di
maiolica delle antiche fabbriche di Pollenza[71].
Questi oggetti, prodotti con molta probabilità dalla stessa vaseria Venanzoli
tra la fine del settecento ed i primi anni dell'ottocento, suscitarono un certo
interesse tanto che Anselmo Anselmi, sulla Nuova Rivista Misena, volle
scrivere, al riguardo, la seguente nota:
Fabbrica
del Vicinato Lungo.
Una prima data certa dell'esistenza
della vaseria dei Ranieri viene dalla Statistica del 1808[75],
relativa al triennio 1806 - 1808, dalla quale apprendiamo che la fabbrica di
Gianfrancesco Ranieri era attiva con un
lavorante, che è il proprietario un pittore à smalto tre operai. Ancora,
sugli esordi della fabbrica, possiamo trarre alcune utili informazioni dal
manoscritto dell'Assortati[76]:
Alcuni atti notarili[80]
dell'epoca dimostrano che la fabbrica, oltre ad appartenere ai due fratelli
Francesco e Giuseppe, era altresì di un terzo fratello sacerdote, il canonico
don Gioacchino, che, stando a quanto scriveva l'Assortati, era un bravo
lavorante ed aiutava i propri fratelli nella loro attività. Vale la pena di
citare ancora un passo del manoscritto dove ci vengono fornite ulteriori
preziose notizie sull'opificio del Vicinato Lungo e non solo:
Come era avvenuto due anni prima il Carassai ed il Rampichini si accordarono nuovamente con gli altri due fabbricanti allora esistenti nel comune, Venanzoli e Rosati, ma il Ranieri si rifiutò di sottostare alle richieste dei due mugnai e preferì, con tenacia e determinazione, agire per via legale.
Il Carassai, nonostante avesse
concordato alcuni anni prima col Ranieri la posizione del macinetto rispetto al
mulino, si giustificava, in una lettera al Prefetto del 5 febbraio 1812[84], con
le seguenti ragioni, non prive di tendenziosità e contraddizioni:
Relativamente alla figura di
Francesco Ranieri ed agli usi, sulla cui liceità preferiamo non esprimerci, di
altri montemilonesi dell'epoca, riportiamo un episodio abbastanza curioso,
desunto da un documento del 30 dicembre 1815, che parla di una singolare
supplica del vasaio all'amministrazione comunale:
Egli
suppone non potere altrimenti perfezionare i lavori necesarj alla fabbrica di
Majolica che debbono eseguirsi ad aria aperta.
Interpellato
l'Amministratore Comunale, si mostra contrario alla domanda, e prende anzi
motivo, che si ordini la chiusura di altri fori abusivamente fatti nelle mura
Castellane. Al voto del Magistrato si unisce ancora quello del generale
Consiglio come dalla Risoluzione annessa.
In questo
stato di cose si propone alla Congregazione di risolvere in massima, che sia
vietato a persona di fare delle aperture nelle Mura Castellane.
La
Congregazione anche sul riflesso d'impedire i furti notturni nelle Campagne
ormai troppo frequenti, crede giusto, che sia rinnovato il divieto di non fare
alcuna apertura nelle Mura Castellane. Queste sono sacre, intangibili, e di
pubblica proprietà. ... Arbitraria, recente è stata l'innovazione fatta dal
Ranieri, e da qualcun'altro che ha abusato delle circostanze de' tempi.
Insussistente
si dichiara il motivo, che questa misura adottata dal Ranieri sia necessaria
per la fabbricazione delle Majoliche. Si eseguiscano pure i lavori ad aria
aperta: non per questo l'artefice non può recarsi al luogo destinato per la
Porta del Paese, che non è grandissimo, come si è praticato in addietro, e come
pratticano altri Fabbricanti.
Queste
porte private infine danno luogo ai contrabandi, si elude il pagamento del
Dazio Consumo ...[86]
La famiglia Bianchedi, originaria di Faenza, è presente a Monte Milone già da prima del 1794 quando, in un atto notarile[87], si nomina Pietro del fu Antonio Bianchedi da Faenza abitante da più anni in questa Terra di Monte Milone. Come sappiamo, la sua presenza nel comune era dovuta al fatto che Francesco Verdinelli Ferrini lo chiamò a lavorare come pittore presso la sua fabbrica, avendo ottenuto la privativa per la fabbricazione della maiolica. Morto il Verdinelli passò a lavorare presso la fabbrica dei fratelli Ranieri suoi cognati. Quest'ultima circostanza è confermata dall'Elenco dei Lavoranti del 1830 ma non sappiamo quando, con precisione, avvenne il passaggio: forse dopo il 1810, allorché gli eredi Verdinelli chiusero momentaneamente la vaseria, o, più probabilmente, dopo la morte di Francesco Verdinelli stesso avvenuta nel 1803. Dal suo matrimonio con Rosa Ranieri, sorella di Francesco e Giuseppe, nacquero Giambattista, Felice e Niccola che proseguirono l'attività degli zii.
Molto poco conosciamo dell'attività
di maiolicai dei fratelli Bianchedi ma sappiamo che direttore della fabbrica fu
Niccola, da prima del 1830, come dimostra ancora l'Elenco dei Lavoranti di
quell'anno. Il suo nome, infatti, figura sempre negli atti ufficiali che riguardano
la vaseria. Così nell'Elenco a Stampa dei Commercianti nella Provincia di
Macerata del 1849[88], nel
Ruolo dei Contribuenti per l'Esercizio del Commercio e dell'Industria dell'anno
1857[89] o
nell'elenco delle ditte partecipanti all'Esposizione Maceratese del 1865[90]. In
una dichiarazione, resa dai fratelli Bianchedi nel 1851[91] e
relativa alla tassa sul commercio per l'anno 1850, leggiamo che gli stessi espongono di essere possessori di una
fabrica di Majoliche ordinarie, avendo nella medesima una sola fornace, e soli
quattro lavoranti compresi i detti tre fratelli proprietari, non avendo in giro
più di un centinaro, e mezzo di scudi per detta fabrica. Se è legittimo
dubitare dei dati forniti nella dichiarazione, perché finalizzata
all'ottenimento di riduzioni sulle tasse, alcuni atti relativi al Ruolo del
1857, invece, dimostrano come la fabbrica dovesse trovarsi in un periodo
davvero difficile dal punto di vista economico. Niccola infatti, diventato nel
frattempo unico proprietario della vaseria[92],
oltre che alcune vicissitudini familiari, era afflitto da numerosi debiti, come
si può leggere in una lettera del Municipio di Monte Milone al Delegato
Apostolico datata 19 settembre 1857[93]:
Niccola Bianchedi di Monte Milone di professione Cocciaro, oratore umilissimo dell'Eccellenza V. R.ma supplica perché in vista della miseria, in cui si trova, voglia degnarsi assolverlo dalla tassa sull'arti e mestieri, a cui non può soddisfare per la sua impotenza. Padre disgraziato di due infelicissimi figli sordo-muti educati dalla carità del Municipio nell'Istituto di Roma incapaci a procurarsi il proprio sostentamento, occupa di continuo le sue braccia per mantenerli col fabricare majoliche, dalle quali non solamente non ricava qualche guadagno, ma di più trovasi gravato da debiti.
Nonostante i problemi economici del
proprietario la vaseria continuò il proprio lavoro tanto che nel 1861, nella
Statistica Minerale, figura ancora attiva con una fornace a carattere
permanente[96].
Quattro anni dopo il nome di Niccola Bianchedi appare nell'elenco delle ditte
partecipanti all'Esposizione Provinciale di Macerata[97].
Particolare questo che lascia supporre una certa ripresa economica della
fabbrica la quale, successivamente al 1862, iniziò a produrre oggetti in
terraglia, riconoscibili per il marchio TBP impresso in pasta.
La mancanza di notizie certe
sull'opificio del Vicinato Lungo fino al 1878 non ci dà la possibilità di
documentare questo periodo di circa tredici anni. Sappiamo tuttavia che fu in
quest'arco di tempo che la vaseria venne ceduta in affitto ad Antonio Bellini,
che figura come direttore della stessa nella Statistica degli Operai del 1878[98]. Dal
documento emerge che la fabbrica occupava 14 operai dai 10 ai 60 anni dalle 8
alle 14 ore giornaliere e in "cinque
buoni locali". Null'altro conosciamo sulla figura del Bellini e sulla
sua produzione. Stando a quanto asserisce il vasaio Benedetti gli successe
nella direzione della fabbrica un certo Nobili Pirro, l'ultimo direttore della
vaseria che chiuse, con molta probabilità, agli inizi del XX secolo.
L'immobile, che era rimasto di
proprietà della famiglia Bianchedi[99],
venne venduto nel 1908[100] da
Francesco, uno dei due figli maschi di Niccola, ad Aristide Marocchi di
professione muratore.
Francesco e Guido, i due figli
sordomuti di Niccola Bianchedi, continuarono a svolgere la professione degli
avi, appresa presso la bottega del padre. Il primo si trasferì a Castellamonte,
dove seguitò a praticare la professione di ceramista[101],
mentre il fratello, pittore, continuò a vivere a Pollenza, lavorando nella
vaseria di Giovanni Venanzoli[102].
|
CRONOLOGIA DELLE FABBRICHE |
|
|
|
|
|
PORTA DEL COLLE |
|
|
Metà ‘600 fino al 1742 |
Famiglia Mariani |
|
Dal 1742 al 1778 |
Catervo Ferrini |
|
Dal 1778 al 1803 |
Francesco Verdinelli Ferrini |
|
Dal 1803 al 1806 |
Antonio Verdinelli |
|
Dal 1806 al 1816 |
Giovanni Verdinelli |
|
Dal 1810 al 1816 |
Inattiva |
|
Dal 1816 al 1853 |
Serafino Verdinelli e Aloisia Fedeli |
|
Dal 1854 al 1865 |
Niccola Benedetti |
|
Dal 1866 al 1887 |
Antonio Farroni |
|
Dal 1887 al 1920 |
Nazzareno Monti |
|
|
|
|
COLLEGIATA |
|
|
Dal 1782 al 1789 |
Marco Caprari |
|
Dal 1789 al 1810 |
Luigi Venanzoli |
|
Dal 1810 al 1839 |
Antonio e Lorenzo Venanzoli |
|
Dal 1839 al 1879 |
Ignazio Venanzoli |
|
Dal 1879 al 1900 |
Giovanni Venanzoli |
|
Dal 1900 al 1911 |
Ignazio Venanzoli |
|
Dal 1911 al 1912 |
Biagio Biagetti e Gaetano Crocetti |
|
|
|
|
VICINATO LUNGO |
|
|
Inizi ottocento prima del 1808 al 1840 circa |
Francesco e Giuseppe Ranieri |
|
Dal 1840 al 1878 circa |
Gianbattista, Felice e Niccola Bianchedi |
|
Dal 1878 agli inizi del ‘900 |
Antonio Bellini e poi Pirro Nobili |
|
|
|
|
VIA DEL BORGO |
|
|
Inizi ottocento |
Marco Caprari |
|
Dal 1807 al 1840 |
Felice Rosati |
|
Dal 1840 al 1850 |
Gaetano, Generoso e Giuseppe Rosati |
|
Dal 1850 al 1856 |
Niccola Benedetti |
|
Dal 1856 al 1880 |
Gaetano e Generoso Rosati |
|
Dal 1886 circa al 1888 |
Luigi Nardi |
|
Dal 1888 agli inizi del ‘900 |
Alessandro Nardi |
|
|
|
|
VIA SANTA MARIA |
|
|
Dal 1851 al 1860 |
Pacifico Sileoni e Beniamino Rosati |
|
Dal 1861 al 1871 |
Serafino Nardi e Niccola Rossetti |
|
Dal 1871 al 1886 circa |
Luigi Nardi |
|
UBICAZIONE DELLE FABBRICHE |
All’interno
delle mura.
1. Fabbrica
di via Santa Maria.
Lungo la via che
tuttora mantiene lo stesso nome e che, un tempo, veniva anche denominata il Vicinatello. All’interno
dell’immobile è presente un orto che non viene indicato sulla mappa.
2. Fabbrica di via del Borgo.
Ubicata in parte lungo
via del Borgo (ora via Leopardi) ed in parte lungo traversa San Francesco.
Sulla mappa catastale è stato evidenziato l’orto, acquistato nel 1824, dove i
Rosati realizzarono l’ampliamento dell’immobile.
3. Fabbrica presso la chiesa collegiata di San Biagio.
Era situata al termine
di via del Vicinato Lungo (ora via XX Settembre) e prospettava, in parte, verso
piazzetta della Collegiata (ora piazzale Marconi) L’immobile è stato demolito
nel 1927 per ampliare lo spazio pubblico.
4. Fabbrica
del Vicinato Lungo.
Ora via XX Settembre.
Sulla mappa si possono distinguere chiaramente tutti gli immobili aggiunti, da
parte dei fratelli Ranieri intorno agli anni 20 del XIX sec., a quello
originario della fornace.
 |
| Figura 3. Mappa catastale di Monte Milone. Catasto Gregoriano. Archivio di Stato Macerata. Diritti Riservati. |
Fuori
dalle mura.
5. Fabbrica
presso la Porta del Colle.
Ubicata extra moenia
lungo l’attuale via Vaseria (l’antica via della Porta del Colle).
 |
| Figura 4. Mappa catastale di Monte Milone. Catasto Gregoriano. Archivio di Stato Macerata. Diritti Riservati. |
[1] Sull'ubicazione delle fabbriche cfr.: Le vaserie nel contesto..., op. cit. pp. 18-21.
[2] Allo scopo verrà utilizzata una mappa catastale dei primi anni dell’800 che rappresenta fedelmente, anche per la seconda metà del ‘700, la conformazione planimetrica del centro storico di Pollenza. A.S. Macerata, Catasto Gregoriano.
[3] Arch. Parr. S. Andrea, Reg. Battesimi, vol. 1711-1797.
[4] A.S. Macerata, Rota, vol. 3772.
[5] A.S. Macerata, Arch. Not. Macerata, vol. 4390.
[6] A.S. Macerata, Arch. Not. Macerata, vol. 4392.
[7] È la casetta, di cui si è già parlato nelle pagine precedenti, che negli anni successivi fu oggetto di contesa tra gli stessi Assortati e Francesco Verdinelli; cfr. supra.
[8] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, vol. 1769-1779.
[9] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, vol. 1780-1790.
[10] A.S. Roma, Camerale III, b. 1439.
[11] Idem.
[12] Ibidem.
[13] Arch. Parr. S. Andrea, Reg. Morti vol. 1790-1857.
[14] A. S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 6147.
[15] L'edificio, come ci rivelerà un atto notarile successivo, è la fabbrica dove il Sileoni e il Rosati svolgevano la loro attività di maiolicai.
[16] A. S. Macerata, Tribunale di prima istanza di Macerata, b. 680.
[17] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.
[18] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1482, f. 7.
[19] A. S. Macerata, Commissario Provinciale, b. 55, f. 303.
[20] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92. È l'elenco dei partecipanti all'esposizione provinciale che si sarebbe dovuta tenere a Macerata nel 1865.
[21] A. S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6155. Come anticipato nella nota 15 è questo l'atto che ci rivela la destinazione dell'immobile in contrada Vicinatello (l'attuale via S. Maria): "una casa da cielo a terra ad uso di fabbrica di Majoliche sita entro questo Comune di Pollenza, contrada Vicinatello, Quartiere Santa Maria, marcata col Numero Civico centonovantadue".
[22] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 57 - 11494.
[23] Circostanza questa non smentita dal racconto del vasaio Nazzareno Benedetti che cita come proprietari della fabbrica Serafino, Benedetto e Luigi, dimenticando però Marino.
[24] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.
[25] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 104 - 20701. Da questo atto si è potuti risalire all'esatta ubicazione in quanto riporta il numero di mappa dell'immobile che è il n. 645, sub. 1.
[26] A.S. Macerata, Notarile di Treia, vol 1289.
[27] G. Corona, Fabbriche di maioliche, op. cit.
[28] Il padre di Felice, Bartolomeo Rosati, appare fra i testimoni alla dettatura del testamento nuncupativo di Giuseppe Verdinelli, padre di Francesco, del 1804; A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 4675.
[29] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1288.
[30] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1289.
[31] Cfr. supra.
[32] A. S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1323 e 1325.
[33] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1331.
[34] Idem.
[35] Ibidem.
[36] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 1358.
[37] Elenco de' commercianti in stato attuale di mercatura nella provincia di Macerata, A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1371, f. 1.
[38] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 959.
[39] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 1482.
[40] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6156.
[41] A.S. Macerata, Commissario Provinciale, b. 55, f. 303.
[42] A.S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 95 e 96.
[43] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6165.
[44] Conservatoria dei RR.II. di Macerata, tit. 18474.
[45] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6156.
[46] Conservatoria dei RR.II. di Macerata, tit. 104 - 20701.
[47] Archivio Notarile Distrettuale di Macerata, notaio C. Curzi, vol. 8.
[48] Idem, vol. 12: Francesco, Raffaele, e Giuseppe Nardi fu Pasquale affittano e rilocano al ridetto Alessandro Nardi accettante: un Fabbricato ad uso di Fabbrica di Stoviglie con orto annesso, posto in Pollenza nella via del Borgo o Traversa San Francesco, distinto col Civico Numero 3, e di Mappa col numero 900 ... Rimangono compresi nel Fondo affittato i Macinetti da colori esistenti nel Vallato del Molino Natalini, e così tutti gli oggetti che esistono nel suddetto fabbricato, come le Tavole, Rote di lavoro, ad eccezione di una di nuovo modello acquistata e messa al posto dallo affittuario Nardi. Siccome pure rimangono esclusi dal contratto, perché di proprietà già dello affittuario Nardi, stante che ne sia stato pagato il valore o non sono stati trovati al cominciare del contratto di affitto, la Vistugia, i Tomboli o Caselle, gli attrezzi in ferro per fare la carbonella e calcinare il colore a pietra per macinarli, il colore macinato e suoi recipienti.
[49] A. S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.
[50] Idem.
[51] Idem, b. 45.
[52] A. Notarile Distrettuale, Notaio Curzio Curzi, Rep. 941 del 23 dicembre 1887.
[53] A.S. Camerino, Società Operaia di Mutuo Soccorso - Camerino, b. 1888 a.
[54] A.P.C., Registri dei Battesimi.
[55] È tuttavia da ipotizzare una breve esperienza del Monti presso la fabbrica Venanzoli, anteriore al 1887, come si rileva ancora dal "Racconto" del vasaio Nazzareno Benedetti.
[56] Sulla figura e l'opera dell'artista e restauratore pollentino Giuseppe Fammilume (1896 - 1952) si veda AA.VV., Giuseppe Fammilume, gli acquerelli, a cura di A. Valentini, Pollenza 1985.
[57] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, Vol. 1780/1790, c. 151r e v.
[58] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 32v-33r.
[59] A.S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 4673.
[60] A.S. Macerata, Notarile Treia, vol. 1268.
[61] A.S. Macerata, Notarile Treia, vol. 1324.
[62] A.S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 1325.
[63] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.1371, f. 1.
[64] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.959.
[65] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.1482. f. 7.
[66] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.
[67] A.S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 95 e 96.
[68] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 87.
[69] Idem, bb. 51 e 85.
[70] Si tratta del figlio di Giovanni che in una lettera, volle attestare la veridicità dell'immagine riprodotta nel disegno: A.C.M.P., busta "Ceramica".
[71] Sul catalogo della mostra possiamo leggere la seguente dicitura: Maioliche delle antiche fabbriche di Pollenza (?...) Cinquanta pezzi - espone Venanzoli Giovanni di Pollenza.
[72] A. Anselmi, Il commercio delle maioliche di Castelli alla antica fiera di Senigallia, op. cit., p. 71, n.1.
[73] Della collezione Venanzoli perduta, crediamo, oramai irrimediabilmente, non si hanno più notizie certe dal 1913 ad oggi.
[74] G. Corona, Fabbriche di maioliche, op. cit.
[75] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.
[76] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 34v-35.
[77] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1331.
[78] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1285.
[79] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1271.
[80] A. S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1271 e 1285.
[81] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 34v-35.
[82] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 5, f. 9.
[83] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.
[84] Idem.
[85] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.
[86] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1383.
[87] A. S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 4480.
[88] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1371, f. 1.
[89] Idem, b. 1482, f. 7.
[90] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92.
[91] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.
[92] La circostanza non è documentata da nessun atto notarile ma è molto probabile che i fratelli, a questa data, gli avessero ceduto la fabbrica tramite scrittura privata, in quanto non appaiono più in nessuno dei documenti esaminati, compresi i testamenti, come proprietari.
[93] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.
[94] Idem.
[95] Ibidem.
[96] A. S. Macerata, Commissario Provinciale, b.55, f. 303.
[97] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92.
[98] Idem, b. 45.
[99] Ad eccezione dell'orto, di proprietà Nozzi.
[100] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 15773.
[101] Idem.
[102] La notizia è tratta ancora dal "racconto" di Nazzareno Benedetti: cfr. supra.
Commenti
Posta un commento