La prima generazione ottocentesca di maiolicari: gli epigoni di Francesco Verdinelli.
Le
fabbriche montemilonesi uscirono indenni dalla fase di stasi che caratterizzò
la vita economica della regione alla fine del XVIII secolo. La stagnazione
degli scambi commerciali e la scarsa circolazione di moneta che
contrassegnarono questo periodo, non dovettero infatti influire più di tanto
sull'andamento delle vaserie le quali anzi, sia pur lentamente, videro crescere
il loro giro di affari: eccezione questa in un quadro più desolante
rappresentato dalla situazione in cui versavano la maggior parte delle
manifatture nei centri limitrofi. Prova evidente, come si vedrà, di una forte
richiesta di prodotto il cui pregio e la cui qualità erano ben conosciuti nelle
principali piazze del centro Italia e non solo. Questa singolarità può essere
spiegata, a nostro avviso, considerando il particolare manufatto che, stando ai
documenti, usciva dalle fornaci di Monte Milone, sicuramente non comune, la cui
offerta era rivolta oramai ai ceti più agiati e non certo a quelli più poveri
sui quali la crisi economica si era abbattuta con maggiore veemenza. Questa
tendenza non si invertì neanche negli anni seguenti, quelli della Prima
Restaurazione o, successivamente, durante il periodo napoleonico quando le
attività manifatturiere della Marca, che nel secolo passato erano riuscite a
sopravvivere all'ombra dei privilegi governativi, «appaiono gravemente
compromesse dalle vicende degli ultimi venti anni e specialmente del periodo
italico, allorché la regione è duramente colpita, col blocco continentale,
dall'esclusione del Mediterraneo orientale dai grandi sviluppi dell'Europa
occidentale e vede accentuarsi, con l'intero Stato pontificio, il ruolo di
fornitrice di materie prime e di generi agricoli»[1]. Ciò
non avvenne certo per Monte Milone, la cui economia dipendeva essenzialmente
dall'esportazione della maiolica, prodotto che, peraltro, doveva essere molto
apprezzato per la sua qualità.
La morte di
Francesco Verdinelli segnò infatti l'inizio di una nuova fase nelle vicende
delle fabbriche montemilonesi. Le sue esperienze, arricchitesi anche, come
abbiamo visto, con l'apporto di influenze esterne alla tradizione del paese,
vennero raccolte da alcuni vasai che lavorarono sotto la sua direzione oltre
che dai suoi eredi diretti. Cessata pertanto la validità della privativa
pontificia, tutte le potenzialità economiche ed artistiche, insite
nell'industria ceramica locale, poterono liberarsi e dare l'avvio a quello che
potremmo definire "il periodo d'oro" della produzione. Sia per l'alto
grado di perfezione tecnica raggiunto, che consentì ai nostri maiolicari di
esprimersi in un repertorio molto vasto di forme e decorazioni a secondo o a
terzo fuoco, sia per i notevoli risultati dal punto di vista del commercio, i
cui benefici non si limitarono ad influenzare un ambito territoriale limitato,
come quello gravante intorno al piccolo centro della Marca, ma si estesero ben
oltre, fino lambire, come vedremo, interessi economici ben più vasti.
Ha così
inizio, agli albori del secolo XIX, un'intensa attività produttiva, che
giungerà al suo apice intorno al 1820-1830, ed il cui livello non verrà mai più
raggiunto da nessun'altra fabbrica del luogo, se si eccettua la felice
parentesi di Giovanni Venanzoli che, qualche decennio più tardi, riuscirà in
parte ad eguagliare i risultati dei suoi illustri predecessori.
È in questo
periodo che venne a costituirsi quell'assetto delle fabbriche che, salvo poche
eccezioni, resterà invariato fino agli inizi del '900. I fratelli Francesco e
Giuseppe Ranieri lasciarono la fabbrica della Porta del Colle dopo il 1803 per
fondarne una nuova nel quartiere di S. Maria, in via del Vicinato Lungo.
Contemporaneamente, un altro lavorante già alle dipendenze del Verdinelli,
Felice Rosati, rilevò la fabbrica della Porta del Colle prendendola in affitto
dagli eredi Verdinelli e successivamente, nel 1807, acquistò l'immobile, in via
del Borgo, dove aveva avuto sede la vaseria del Caprari.
La
situazione all'indomani della morte del Verdinelli ci è nota attraverso una
coeva testimonianza scritta di Domenico Assortati che, in uno dei suoi diari,
parla così delle botteghe e dei loro
proprietari: … presentemente sono tré, le
quali fanno a gara di sorpassarsi l'una con l'altra. Dopo la morte del Sig.
Francesco Verdinelli, il quale veramente lavorava, e teneva lavoranti buoni
tanto nella majolica bianca, che dipinta, che era l'unico in Provincia, è ora
subbentrato in sua vece il Sig. Antonio Venanzoli stato prima Lavorante del
suddetto Verdinelli, il quale procurato ha d'imitare il suddetto.
Vi è anche un certo Francesco
Ranieri, il quale ha aperta nuova Bottega, e lavora al pari del suddetto
Venanzoli. Per l'infima si pone la Bottega di Felice Rosati, il quale tiene a
nolo la Bottega del Suddetto Verdinelli, ma non si può confrontare con i
suddetti per il motivo delle Vasa più belle, e nella pittura, e nel bianco, ma
ciò non ostante ha dello smercio, e spesa molte famiglie anche questi. I
suddetti sono stati tutti Lavoranti del ridetto Sig. Verdinelli, mentre dopo la
sua morte, gli eredi dovettero chiudere, e lasciare il negozio, e perché il suo
figlio Giovanni non vuolle attenderci, e perché furono anche mal consigliati,
per cui si sono ridotti in grande miseria, vivendo a stento giornalmente[2].
Quanto alla
fondazione della fabbrica dei fratelli Francesco e Giuseppe Ranieri, ci si
imbatte nella difficoltà di non avere un atto notarile che documenti il periodo
in cui venne acquistato o affittato l'immobile. Basandoci ancora su quanto
asserito dall'Assortati e su uno scritto del Corona [3],
Francesco aveva lavorato dal Verdinelli ed è presso la sua fabbrica che si
formò come maiolicaro. Questa circostanza potrebbe essere avvalorata dal fatto
che la sorella, Rosa Ranieri, sposò uno dei pittori della fabbrica Verdinelli
Ferrini, Pietro Bianchedi[4]: ciò
a dimostrazione di un rapporto di stima o di amicizia che poteva essersi
formato quando i Ranieri erano ancora lavoranti presso Francesco Verdinelli,
visto che il matrimonio risale a prima della morte di quest'ultimo avvenuta nel
1803.
Una prima
data certa dell'esistenza della vaseria dei Ranieri viene da una Statistica del
1808, relativa al triennio 1806 - 1808, dalla quale apprendiamo che la fabbrica
di Gianfrancesco Ranieri era attiva con un
lavorante, che è il proprietario un pittore à smalto tre operai[5].
Ancora,
sugli esordi della fabbrica, possiamo trarre alcune utili informazioni dal
manoscritto dell'Assortati: I ... Fratelli Ranieri son Figli
delli conjugi Antonicola Ranieri e Maria .... Dal matrimonio di essi Conjugi
Ranieri sono, Rosa maritata con un tal Pietro Bianchedi di Faenza, quà capitato
a dipingere le Vasa nella Bottega Verdinelli, ed hanno una buona figliolanza.
Antonia Consorte di Tommaso Piccioni Archibugiere, e bravo lavorante di forno,
.... Il Canonico Don Gioacchino dopo esser stato tenuto in Seminario di
Macerata ... ajuta i suoi Fratelli nel negozio della Vasaria col far delle
forme, ed altro occorrente. Ha fatti tre grandi Crocifissi, due dei quali si
vedono nell'Oratorio novellamente eretto ... Il detto Francesco dopo che
riunissi colli suoi Fratelli attendendo al Detto negozio di Vasaria, ha fatto
delli molti acquisti anche in terreni, ed al presente ha una buona entrata.[6]
Dei due
crocifissi presenti nell'ex oratorio di S. Antonio Abate a Pollenza ne resta
fortunatamente uno (Foto 1), ora custodito nei locali dove ha sede la
Confraternita del Preziosissimo Sangue che ne è, come all'epoca dell'Assortati,
ancora proprietaria.
 |
Foto 1. Crocifisso in terracotta verniciata a freddo. Monte Milone, Don Gioacchino Ranieri, Fabbrica Ranieri, 1823 circa. Pollenza, sede della Confraternita del Preziosissimo Sangue. |
Un'altra
attribuzione certa nell'ambito della produzione in maiolica delle fabbriche
montemilonesi degli inizi del XIX, è un interessante centro pavimentale tuttora
esistente in una casa ubicata nel quartiere di S. Maria, proprio di fronte a
quella che fu la fabbrica dei fratelli Ranieri[7].
 |
Foto 2. Cento pavimentale in maiolica, dim. 265 x 265 cm. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX. Collezione Privata. Particolare del riquadro centrale con il paesaggio.
Esso è composto da un paesaggio (Foto 2), che rappresenta la foce di un fiume, con un ponte, un torrione, alcune barche e la campagna circostante, dove appaiono alcune scene agresti con due contadini intenti nel loro lavoro (in basso al centro), due carri trainati da buoi (in basso a sinistra), ed altri buoi al pascolo (più in alto a destra). La gamma cromatica di questa scena centrale va dal giallo, all'azzurro, al verde, ocra e marrone. Fanno da cornice due riquadri neri con interposta una teoria di piastrelle a fondo bianco e decorazioni fitomorfiche in verde e in blu. Completano il centro pavimentale due altre cornici più esterne: quella intermedia consta di una serie di piastrelle rotonde, decorate anch'esse a paesaggi (Foto 3), mentre sulla perimetrale troviamo gli stessi motivi fitomorfici su fondo bianco di quella del paesaggio centrale.
 |
Foto 3. Cento pavimentale in maiolica. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX sec. Piastrelle circolari nella cornice intermedia. |
Non
crediamo possa essere messa in dubbio l'attribuzione di questo pavimento ad una
delle quattro fabbriche esistenti a Monte Milone nel primo quarto del XIX
secolo. Non tanto perché difficilmente l'anonimo committente dell'opera si
sarebbe rivolto ad altri centri, quali ad esempio Castelli o Ascoli[8], con
la produzione presente in paese ma, soprattutto, perché di recente, a seguito
di lavori di restauro dell'immobile, il pavimento è stato staccato e ricollocato
in situ: il suo letto di posa
risultava composto, oltre che di malta di calce, di numerosi scarti di fornace
di piastrelle simili a quelle in vista e da numerosi frammenti di muffole da
piccolo fuoco con delle scolature, cotte in fornace, dello stesso smalto
cilestrino usato per il pavimento (Foto 5).
 |
Foto 4. Cento pavimentale in maiolica. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX sec. Piastrella angolare. |
 |
Foto 5. Scarti di fornace rinvenuti sotto il centro pavimentale in maiolica. |
Nella stessa casa erano presenti i piatti
murati e i balaustri della scala rappresentati nelle foto d’epoca delle foto 6
e 7.
Un elemento
decorativo che doveva caratterizzare la produzione a secondo fuoco di questo
periodo è quello a filettature in blu. Lo ritroviamo nel vassoietto centinato
della foto 8 che, oltre alle decorazioni a secondo fuoco, presenta alcune parti
realizzate con colori a smalto applicate a completamento del disegno
sottostante. In questo caso, alle caratteristiche filettature in blu si associa
una composizione, riccamente policroma, nella quale un cartiglio rocaille in giallo, blu, e fondo verde
ramina e celeste, interamente realizzato a gran fuoco, è contornato da
composizioni floreali. Quella in basso, consistente in due ramoscelli fioriti,
presenta i petali in blu, gli steli in bruno di manganese e le foglie in un
verde ramina molto tenue ravvivato da alcune pennellate di colore verde a
smalto, dato quindi in una terza cottura dell'oggetto. Il medesimo discorso
vale per le foglie dell'altra composizione, a festoni, dove il colore a smalto
compare anche nei petali dei due fiori ocracei. Lo stesso tipo di composizione
floreale e tecnica appaiono nella decorazione delle quattro piastrelle
angolari, adiacenti alla cornice nera interna, del centro pavimentale sopra
esaminato (Foto 4) tanto da indurci a credere che siano attribuibili allo
stesso anonimo pittore.
La
situazione degli opifici agli albori del secolo è ben illustrata dalla
statistica del 1808 (Figura 9) dove
appaiono quattro fabbriche di maiolica attive nel comune di Monte Milone.
L'importante documento, oltre alla situazione economica negli anni 1806, 1807 e
1808, testimonia una caratteristica fondamentale degli stessi, ovvero quella di
disporre, nella quasi totalità, di un pittore a smalto per la decorazione delle
maioliche. Conferma inequivocabile della permanenza di una tradizione,
instauratasi nel terzo quarto del XVIII secolo presso la fabbrica della Porta
del Colle, la quale continuò per opera di quei vasai che qui l'appresero e
contribuirono a perfezionarla. Le quattro fabbriche che figurano nel quadro
statistico, inviato dal Podestà di Monte Milone al Prefetto del Musone in data
5 settembre 1808, sono quella dei fratelli Lorenzo ed Antonio Venanzoli, che
subentrarono nella direzione al padre Luigi prima che questi morisse, quella di
Giovanni Verdinelli[9],
quella di Gianfrancesco Ranieri e, infine, quella di Felice Rosati, l'unica a
non disporre di un pittore a smalto. Gli uomini impiegati nelle manifatture
risultavano essere 28 in tutto e, relativamente alle notizie sull'andamento
economico nel 1806-1807, possiamo leggere che Poca differenza si ravvisa fra l'uno e l'altro anno, mentre per il
1808 l'attività sperimenta decremento
perché non trovano Piombi, e stagno, e non hanno gran smercio per la scarsezza
di moneta.
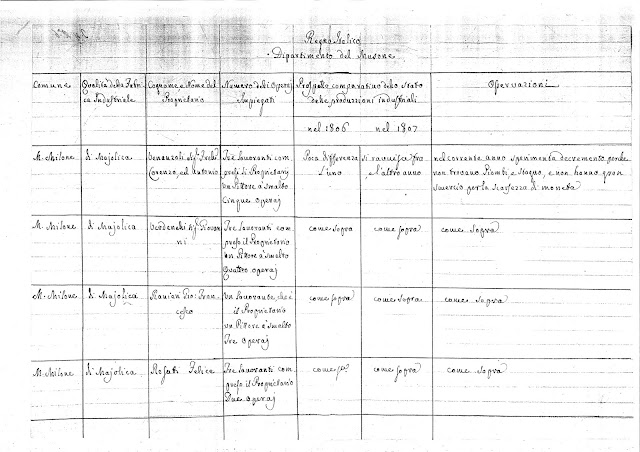 |
| Figura 9. Statistica Minerale del 1808. Quadro con la situazione delle fabbriche negli anni 1806-1807 (su concessione del Min. Beni e Attività Culturali – Diritti Riservati). |
Da un'altra
statistica, datata 1809, apprendiamo ulteriori notizie sulla produzione e sul
suo smercio: Le manifatture principali
della Comune si riducono in quattro Fabriche di Maioliche colorate, e minate a
smalto, le quali Fabriche lavorano anche vasellami inferiori... Si trasportano
dette Manifatture non solo nelle limitrofe Comuni, e nelle principali dei tre
Dipartimenti, ma anche fuori di Stato. La quantità precisa non può
determinarsi, perché giammai non se ne è fatto intro l'anno alcun calcolo;
bensì può motivarsi, che da queste manifatture ritraggono la necessaria
sussistenza moltissime Famiglie le più bisognose... Vengono introitate nella
Comune... Legnami, Piombi, Stagni, e Colori... In quanto alle Fabriche di
Maioliche sarrebbero da incoragire, quante le volte l'introduzione de Piombi,
Stagni, e Minerali indispensabili articoli per la manifatture delle medesime si
potesse ottenere con risparmio minore di Dazi, e si togliesse la difficcoltà di
averli, come ancora se fosse facile lo smercio de lavori stessi, ciò che ora
non accade per la deficienza del numerario[10].
La
differenziazione operata nel documento fra maiolica colorata e quella miniata a smalto costituisce una
prova evidente delle due diverse produzioni presenti nelle fabbriche:
tradizionale la prima, ovvero a gran fuoco, e frutto di influenze esterne la
seconda, quella cioè decorata a piccolo fuoco.
È molto
difficile, allo stato attuale delle conoscenze, tracciare un quadro abbastanza
completo dei caratteri che contraddistinguono la produzione in questi anni la
quale, come dimostrano i documenti fin qui esaminati o quelli che avremo modo
di vedere più avanti, era non solo molto copiosa, ma anche di un livello
qualitativo abbastanza elevato dovuto, come sappiamo, alle decorazioni a smalto
con le quali almeno tre vaserie, sulle quattro esistenti, potevano impreziosire
le loro maioliche. L'utilizzo di questa tecnica permarrà, nella produzione di
maiolica montemilonese, almeno fino a quando fu attiva la prima generazione
ottocentesca di maiolicari e sicuramente fino al 1825, come si legge in un
documento di quell'anno nel quale Antonio Venanzoli dichiara di fabbricare Maioliche si bianche, che colorate, e
miniate, ovvero decorate con colori a smalto[11].
Relativamente
alla produzione degli inizi del XIX sec. si deve ricordare, ancora, lo studio
di Erika Terenzi del 1998 dove vengono individuati, per la prima volta, alcuni
oggetti ed alcune tipologie di decori realizzati dalle nostre fabbriche[12]: «All’interno
della produzione montemilonese si assiste nel tempo ad una graduale evoluzione
iniziata nel secolo XVIII … avvicinandosi sempre più al definitivo gusto
neoclassico: da una forma fortemente barocca, ad una più geometrica … fino alle
lineari caffettiere ginoriane. Anche la rosa montemilonese subisce delle
trasformazioni: la briosa rosa settecentesca cede il posto ad una di iniziale
ispirazione ginoriana che negli anni, pur mantenendo quest’indole, verrà
modificata, personalizzata e riprodotta con la sua ricorrente tipologia, in
tutte le decorazioni del XIX secolo; l’ovoidale rosa settecentesca, si evolve
in una ogivale, esasperando la sua iniziale forma e natura». Un altro esempio
«il tipico garofano settecentesco … caratterizzato da un petalo appassito che
si interseca ad un altro, disegnando una V. Questo particolare fiore … è
presente anche nelle successive composizioni floreali seguite dai maiolicari
del XIX secolo nella realizzazione del tipico bouquet ottocentesco». Di questa
particolare produzione riporto, a titolo esemplificativo, alcuni oggetti
rappresentati nelle foto 10, 11 e 12.
 |
Foto 12. Caffettiera in maiolica. Monte Milone, inizi XIX sec. Mercato antiquario. La forma richiama esempi ginoriani ed è decorata con il bouquet alla rosa ogivale con il tulipano che ripete un modello già presente nella produzione di fine ‘700. https://wannenesgroup.com/wp-content/uploads/cssas/lotimages/hd/01891_0315_.jpg |
Continuando
ora l'esame di questo periodo, particolarmente ricco di fonti archivistiche,
dobbiamo citare un'altra statistica relativa agli anni 1811-1812, che fornisce
altri importanti elementi. Innanzitutto una crescita economica, in quanto il
numero di operai impiegato nelle fabbriche passa dalle 28 unità del 1808 alle
36 del 1812[13].
Oltre a ciò il documento ci informa che il numero delle vaserie si era ridotto
a tre per la chiusura momentanea di quella degli eredi Verdinelli, sino al
1816, anno in cui venne riaperta da Serafino, figlio minore di Francesco:
eccezione questa in un quadro economico generale sostanzialmente stabile nel
quale le altre fabbriche, al contrario, si caratterizzarono per una crescita
costante e per un relativo benessere economico[14].
Francesco
Verdinelli morì il 3 febbraio 1803[15]. Dal
suo testamento nuncupativo, dettato al notaio Giuseppe Maria Lisi poche ore
prima di morire, risultano eredi i tre figli maschi Giovanni, Tommaso, Serafino
e la moglie Marianna usufruttuaria. Nello stesso atto il testatore nominò pure
quest'ultima, insieme al padre Giuseppe, come tutori e curatori dei tre figli
minorenni[16].
L'anno successivo, il 15 gennaio, Giuseppe Verdinelli, oramai infermo e giacente in letto dettò le sue ultime volontà e
dispose che, constatata l'abilità e fedeltà dell'altro suo figlio Antonio nel negozio di majolica ordina, e commanda
che il medesimo assieme con la signora Marianna vedova relitta del fu Francesco
Verdinelli altro Figlio premorto, abbia l'amministrazione generale in detto
negozio ... e ciò sino all'età maggiore di qualcuno di detti suoi nipoti[17].
L'attività di Antonio Verdinelli come direttore della fabbrica della Porta del
Colle non dovette durare più di qualche mese poiché, come sappiamo, questa
venne ceduta in affitto al Rosati. Soltanto intorno al 1806 Giovanni, giunto
oramai alla maggiore età, poté prendere la direzione della fabbrica che tornò
così sotto il pieno possesso della famiglia Verdinelli.
In questo
periodo iniziò anche il lento ed inesorabile declino della vaseria i cui
affari, dopo la morte di Francesco, non dovettero andare molto bene se, come
testimonia un atto notarile del 1807, Giuseppe, ancora vivente, fu costretto
alla vendita di un credito fruttifero del valore di 62 scudi e 50 bajocchi onde
pagarci alcuni debiti Secchi, che ha
dovuto contrarre con diverse persone per il mantenimento della sua Famiglia, e
Negozio di Vaseria[18].
Nonostante
dalla statistica del 1808 appaia una situazione sostanzialmente simile a quella
delle altre, sia da un punto di vista economico che per il numero di
dipendenti, tre lavoranti, un pittore a smalto e quattro operai[19], la
fabbrica Verdinelli si avviò verso una crisi che la portò alla chiusura intorno
al 1810[20].
Questo periodo di inattività durò circa sei anni dopodiché nel 1816 Giovanni,
in qualità di proprietario nonché di curatore dei due fratelli minori, vendette
una casa con un piccolo terreno annesso contiguo alla vaseria con la riserva della strada intorno a detta Casa,
che porta in detta Vaseria, cioè a mezzogiorno, ed il picciolo spazio in uso
dell'espanzione delle coccie per la somma di 100 scudi con lo scopo di
servirsene per riaprire la Fabrica della
Majolica, e per impiegare in detta Fabrica Serafino Fratello minore, che si
trova senza mezzi d'impiegarsi con vantaggio[21].
Le vicende
della vaseria in questi anni mostrano un andamento anomalo rispetto a quello
delle altre che, lo abbiamo visto nelle pagine precedenti, stavano
attraversando un momento estremamente florido. Non sappiamo spiegarci a fondo
il perchè di questa eccezione, proprio nel momento d'oro della produzione, per
la quale la più antica e rinomata delle fabbriche imboccò il cammino di un
lento declino che la porterà, pochi anni dopo e nonostante l'impegno che vi
profusero i proprietari, al fallimento economico. Certo è che mancò agli eredi
Verdinelli l'apporto di quegli uomini di cui aveva potuto disporre il padre,
fra i quali gli stessi che alla morte di Francesco iniziarono una propria
attività o coloro che, dopo la chiusura del 1810, se ne andarono a lavorare in
altri opifici del paese. Riaprire una fabbrica di maioliche dopo 6 anni di
inattività significava soprattutto una difficile ricostruzione del patrimonio
di esperienze artistiche e di risorse umane oramai irrecuperabile, tanto da
indurci a credere che buona parte dei motivi che determinarono questa
situazione stava nella qualità del prodotto non più in grado di competere con
quello delle altre fabbriche.
In effetti
gli anni che seguirono videro sempre più affievolirsi la vitalità della Vaseria
che oramai, lungi dall'essere una fonte di guadagno, costringeva piuttosto i
proprietari ad indebitarsi sempre più ed a dismettere persino i propri capitali
per il suo mantenimento[22]. Si
arrivò così nel gennaio 1828 a gravare di un'ipoteca, per 150 scudi, lo stesso
immobile dove aveva sede la fabbrica e, poco tempo dopo, schiacciati dai
debiti, i tre fratelli si trovarono costretti a venderlo per appianare la loro
disastrosa situazione economica[23].
L'atto di
compravendita, rogato in data 16 maggio 1828, ci informa che l'acquirente era
un certo Antonio Fedeli, medico condotto del paese, il quale acquistò la
fabbrica, insieme agli attrezzi in essa contenuti e ai macinetti da colori sul
fiume Potenza, per la somma di 550 scudi[24].
Sappiamo, tuttavia, che lo stesso era anche il suocero di Serafino e che,
pertanto, l'acquisto della fabbrica fu soltanto una mossa che avrebbe salvato
la figlia e i suoi familiari da una difficile situazione economica, tanto che
la direzione della vaseria rimase stabilmente nelle mani del genero il quale,
una volta appianati i propri debiti e quelli dei suoi fratelli, poté continuare
per parecchi anni ancora la propria attività di maiolicaro.
Poche le
notizie sulla famiglia Verdinelli negli anni successivi[25]. I
documenti tacciono almeno fino al 1848 quando la fabbrica viene nominata in una
statistica dello stesso anno[26]. Nel
1849 troviamo il nome di Serafino Verdinelli nell'Elenco a Stampa dei
Commercianti della Provincia di Macerata[27],
mentre nel 1850, in un Ruolo dei Contribuenti per la Tassa di Esercizio delle
Arti[28],
viene citato come fabbricante di mezza maiolica e maiolica ordinaria con lavoranti tre e un capitale di scudi 140.
Risulta evidente la differenza tra questo numero di dipendenti e quello del
1830. Ciò è ovviamente attribuibile alla crisi economica che colpì questa, come
le altre fabbriche, intorno alla metà del secolo. Il difficile momento per gli
opifici montemilonesi determinò l'abbandono dell'attività, da parte del
Verdinelli, che avvenne dopo il 1853, quando nei documenti ancora viene
definito "fabbricante", o comunque prima del 1857, in quanto il suo
nome non compare più fra quelli degli altri maiolicari nel Ruolo dei
Contribuenti dello stesso anno[29].
A questa
ultima fase della produzione della fabbrica Verdinelli appartiene la lampada in
maiolica della foto 13, unico pezzo attribuibile con certezza alla fabbrica
sotto la direzione di Serafino e la Moglie, che riporta sulla bocca la seguente
dicitura: Aloisia Verdinelli Fecit 1851
per il Comune di S. Elpidio.

Foto 13b. Bocca della lampada con la scritta Aloisias Verdinelli S. Elpidio a Mari l'anno
1851 Fecit.

Foto 13b. Bocca della lampada con la scritta Aloisias Verdinelli S. Elpidio a Mari l'anno 1851 Fecit.
Infatti, nel
1846, Antonio Fedeli aveva ceduto l'immobile della vaseria alla figlia Luigia, e per essa accettante il Signor Serafino
Verdinelli[30],
in parziale liquidazione della dote. Qualche anno dopo, il 31 dicembre 1853, i
coniugi Verdinelli decisero di vendere il fabbricato a Vincenzo Moroni, un
possidente montemilonese, per la somma di 450 scudi circa[31].
[1] D. Fioretti, Persistenze e mutamenti..., cit., p. 83.
[2] Il testo è contenuto in un
foglio manoscritto di D. Assortati, residuo di uno dei suoi diari, conservato
presso l'Archivio della "Corporazione del Melograno" di Pollenza con
il n. 68 di protocollo.
[3] G. Corona, La Ceramica, Esposizione Industriale Italiana
del 1881 a Milano. Relazione dei Giurati, Milano 1885, pp. 73-74.
[4] La famiglia Bianchedi,
originaria di Faenza, è presente a Monte Milone già da prima del 1794 quando,
in un atto notarile si nomina Pietro del fu Antonio Bianchedi da Faenza
abitante da più anni in questa Terra di Monte Milone. A. S. Macerata, Notarile
di Macerata, vol. 4480.
[5] A. S. Macerata, Dipartimento
del Musone, b. 22.
[6] D. Assortati, Notizie..., cit., cc. 34v-35.
[7] Sull'ubicazione delle
fabbriche in ambito urbano cfr. A. Nardi, M. T. Stura, Le Fabbriche nel Contesto Urbano di Monte Milone, in A. Valentini
(a cura di), La Ceramica …, cit., pp.
17-21.
[8] Non possiamo sottacere le
evidenti affinità dei paesaggi presenti nel pavimento, o del vassoietto della
foto **, con quelli attribuiti alla manifattura Paci di Ascoli Piceno quali, ad
esempio, quelli conservati presso La Pinacoteca Civica di Ripatransone. Cfr. al
riguardo S. Papetti, Maioliche e
terraglie in Ascoli Piceno, in G. C. Bojani (a cura di), Fatti di Ceramica nelle Marche, Milano
1997, pp. 225-228 o, dello stesso autore,
Ascoli Piceno. Pinacoteca Civica. Disegni, maioliche, porcellane, Bologna
1995. Relativamente a queste o anche altre affinità fra la produzione ascolana
e quella montemilonese riteniamo si dovrà far luce con maggiore chiarezza,
anche sulla base di ulteriore documentazione che allo stato attuale non si ha a
disposizione. Tuttavia possiamo in questa sede limitarci a rilevare come,
secondo il Papetti, nei paesaggi ascolani sia completamente assente la figura
umana a differenza del pavimento in questione dove questa compare in gran
copia.
[9] Era il figlio primogenito di
Francesco Verdinelli.
[10] A. S. Macerata, Dipartimento
del Musone, b. 127.
[11] A. S. Roma, Camerlengato
parte II, b. 35.
[12] Erika Terenzi, La maiolica …, cit., pag. 76 e segg.
[13] A. S. Macerata, Dipartimento
del Musone, b. 124.
[14] Tutto questo è dimostrato,
ad esempio, dai numerosi investimenti in case e terreni effettuati dai
fabbricanti, come si riscontra da diversi rogiti notarili. Così, ad esempio in
A.S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1172, 1269, 1271, 1280, 1281, 1282, 1285,
1286, 1288, 1289, 1291, 1310, 1312, 1314, 1820.
[15] La data risulta dal Registro dei Morti
dell'Archivio Parrocchiale e Capitolare della Collegiata di San Biagio in
Pollenza.
[16] A.S. Macerata, Notarile di
Macerata, vol. 4675.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem, Notarile di Treia,
vol. 1279.
[19] A.S. Macerata, Dipartimento
del Musone, b. 22.
[20] Questa data si deduce dal
fatto che nella Statistica del 1809 risultavano attive quattro fabbriche
mentre, in quella degli anni 1811-1812 ne risultano attive soltanto tre. Cfr.
supra.
[21] A.S. Macerata, Notarile di
Macerata, vol. 5180.
[22] In questo senso possono
parlare, ad esempio, alcuni atti nei voll. 1269 e 1284 del Notarile di Treia.
[23] A.S. Macerata, Notarile di
Treia, vol 1269.
[24] Ibidem, vol. 1313.
[25] Sappiamo comunque da un 'elenco
degli occupati nelle fabbriche del 1830 che la fabbrica si avvaleva, in
quell'anno, di 20 dipendenti. A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 866.
[26] A.S. Macerata, Delegazione
Apostolica, b. 1358.
[27] Ibidem, b. 1371, f. 1.
[28] Ibidem, b. 959.
[29] Ibidem, b. 1482.
[30] A.S. Macerata, Notarile di
Treia, vol. 1394.
[31] Ibidem.












Commenti
Posta un commento